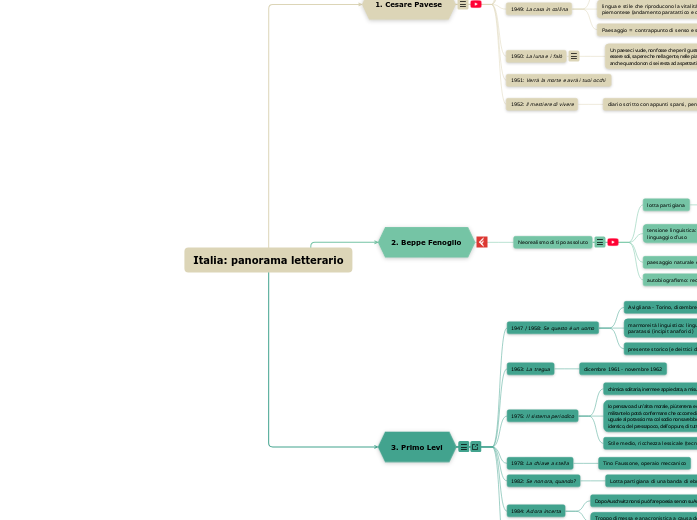Italia: panorama letterario
Cesare Pavese
senso doloroso di una vita reale
solitudine e senso di morte
ritorno al mondo rurale come luogo salvifico
lingua semplice e quotidiana
POESIA RACCONTO
1941: Paesi tuoi
1947: Dialoghi con Leucò
27 dialoghi tra personaggi della mitologia classica
rapporto tra storia e mito e quello tra uomo e natura
1949: La casa in collina
romanzo breve e autobiografico
lingua e stile che riproducono la vitalità della cultura contadina piemontese (andamento paratattico e dialoghi)
Paesaggio = contrappunto di senso e sentimento
1950: La luna e i falò
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.
1951: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
1952: Il mestiere di vivere
diario scritto con appunti sparsi, pensieri e sensazioni
Nella sua vita, Cesare Pavese si sentì sempre estraneo al mondo e agli altri uomini, si sentiva altrove. Questa percezione deriva da un ossessivo scavo interiore, che lo porterà al suicidio.
Beppe Fenoglio
lotta partigiana
non mito ma dramma
tensione linguistica: sottrarre l'epica resistenziale alla banalità del linguaggio d'uso
contaminazione dialettale (lessico e sintassi)
effetti di arcaica semplicità ed essenzialità
fenglese
gioco di scambi e calchi reciproci
paesaggio naturale emblema della durezza dei rapporti umani
autobiografismo: recupero della memoria famigliare
Primo Levi
1947 / 1958: Se questo è un uomo
Avigliana - Torino, dicembre 1945 - gennaio 1947
marmoreità linguistica: lingua essenziale, precisione degli aggettivi, paratassi (incipit anaforici)
presente storico (e deittici della prossimità)
1963: La tregua
dicembre 1961 - novembre 1962
1975: Il sistema periodico
chimica solitaria, inerme e appiedata, a misura d'uomo
Io pensavo ad un'altra morale, più terrena e concreta, e credo che ogni chimico militante lo potrà confermare: che occorre diffidare dal quasi uguale (il sodio è quasi uguale al potassio: ma col sodio non sarebbe successo nulla), del praticamente identico, del pressapoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi
Stile medio, ricchezza lessicale (tecnicismi)
1978: La chiave a stella
Tino Faussone, operaio meccanico
1982: Se non ora, quando?
Lotta partigiana di una banda di ebrei russi e polacchi
1984: Ad ora incerta
Dopo Auschwitz non si può fare poesia se non su Auschwitz
Troppo dimessa e anacronistica a causa del suo tono semplice e comunicativo, destinato al lettore comune
1986: I sommersi e i salvati
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perchè ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre.
Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti.