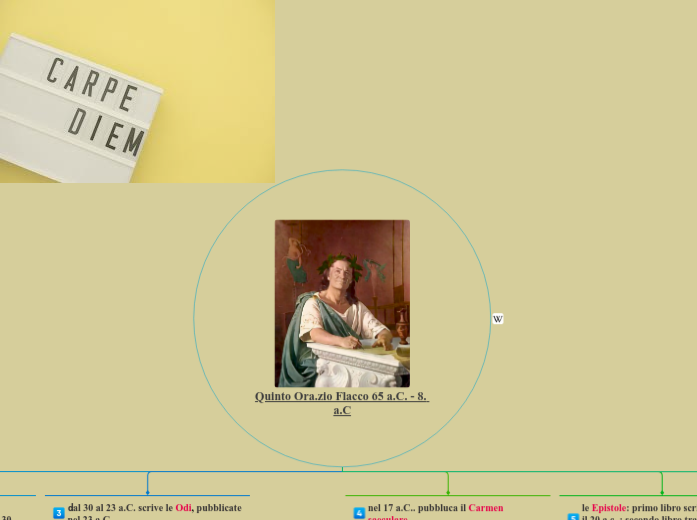Quinto Ora.zio Flacco 65 a.C. - 8. a.C
nel 41-30 a.C.. compone le Satire (Sermones, per il poeta), pubblicate nel 35-33 a.C.
Le satire oraziane presuppongono un sostrato di concetti morali. i principi alla base delle satire sono:
• metriotes ( senso della misura): la virtù consiste nel giusto mezzo, nell’equilibrio tra gli estremi opposti;
• autarkeia (autosufficienza): limitazione dei desideri per evitare i condizionamenti esterni che impediscono di raggiungere la piena libertà interiore.
la riflessione delle satire si orienta verso la morale pratica e mirante a quella serenità che è l’essenza della felicità.
L’autore si presenta non tanto come un saggio quanto come un individuo che ricerca la verità prima di tutto per se stesso
nel 41 -30 a.C. compone gli Epodi (iambi, per il poeta) pubblicati nel 30 a.C.
negli epodi, da un lato critica i personaggi tipici, come l'usuraio e l'arricchito, le maghe e matrone invecchiate nel corpo ma non nei desideri; dall'altro lato, esalta il tema dell'amore e del convito, dell'impegno civile e la riflessione sulla società politica.
dal 30 al 23 a.C. scrive le Odi, pubblicate nel 23 a.C.
nelle odi emerge la coscienza dell’incertezza del futuro e della brevità della vita, che ha come sviluppo positivo la virile sopportazione delle avversità, come sviluppo negativo la constatazione della brevità della vita (motivo del carpe diem).

carpe diem
Lettura in metrica
Traduzione in italiano
nel 17 a.C.. pubbluca il Carmen saeculare
il Carmen saeculare ha la funzione originaria dell’inno; la celebrazione di Roma e della sua gloria immortale e l’esaltazione di Augusto, autore della grandezza e della prosperità dello stato.
le Epistole: primo libro scritto tra il 23 e il 20 a.c..; secondo libro tra il 19 e il 13 a.C..
In quest'opera Orazio parla in maniera colloquiale, da un punto di vista personale, con arguzia e buon senso; non è più il poeta cinico e arguto delle Satire ma un poeta conscio delle proprie debolezze e delle sue contraddizioni: quell'equilibrio tra autarkeia e metriotes, così fondamentale nelle Satire, adesso viene a mancare.
Il poeta romano sente un impellente bisogno di ricerca morale e di saggezza filosofica, ma non riesce più a proporre, né per sé né per gli altri, un modello di vita soddisfacente. Le sue incertezze morali incalzano, e l’insoddisfazione di sé aumenta, Orazio è in preda ad una strenua inertia, ad una noia angosciosa e impaziente che lo rode dal di dentro.
Ars poetica: epistola ai Pisoni tra il 20 o 15 a.C.
E’ una sorta di trattato in versi. Esercitò un enorme influsso nelle età successive. Rivolgendosi a Pisone e ai suoi figli, Orazio espone i precetti di poetica.. Egli tratta prima della poesia poi del perfetto poeta.. Orazio enuncia inoltre due principi di estetica fondamentali:
1. l’idea che la grande poesia è contemporaneamente frutto dell’ingenium e dell’ars.
2. la poesia sa miscere utile dulci, dilettando e insieme insegnando.