da Elio Cosentino mancano 4 anni
768
La Globalizzazione
Il fenomeno della globalizzazione ha reso le economie dei vari Paesi sempre più interconnesse, portando alla diffusione di prodotti tipici di una determinata località in tutto il mondo.
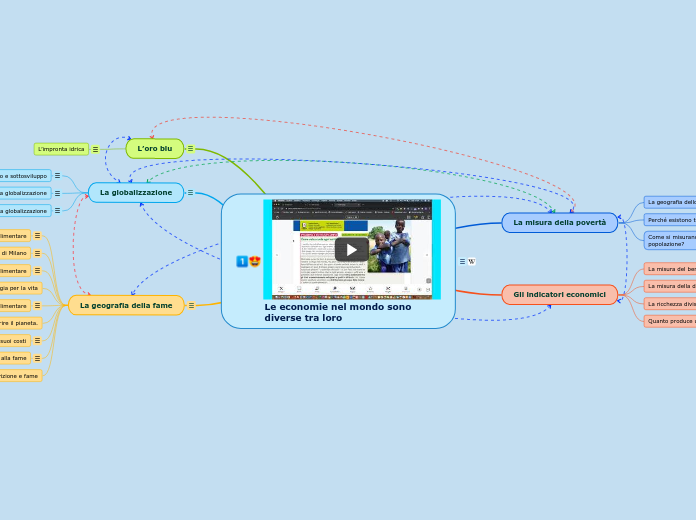
da Elio Cosentino mancano 4 anni
768
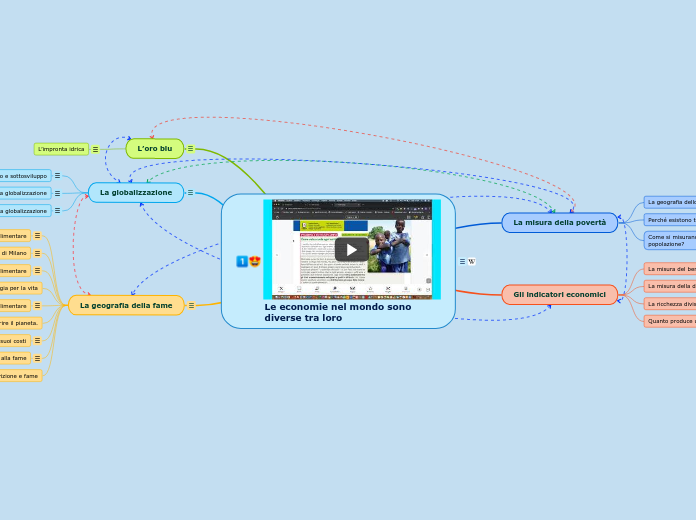
Più simili a questo
La «globalizzazione» è quel fenomeno per cui le economie di Paesi differenti diventano sempre più dipendenti l’una dall’altra. I prodotti tipici di una determinata località sono commercializzati nel resto del mondo, e questo fa sì che i gusti e i bisogni delle persone si assomiglino un po’ ovunque. Ma stiamo davvero diventando tutti uguali, abbiamo tutti le stesse opportunità?
La Vespa esportata in Cina è un esempio di come i beni di consumo si diffondono da un Paese all’altro. Quando pensiamo alla globalizzazione, il primo pensiero va alle grandi multinazionali: mangiamo tutti nella stessa catena di fast food, compriamo le stesse scarpe sportive, beviamo le stesse bibite. Ci sono molti aspetti della vita quotidiana di altri Paesi che stanno diventando anche nostri: la cucina orientale, le jeep americane sulle strade di città, le fasce di stoffa per portare i neonati che abbiamo «importato» dal continente africano ecc. Viceversa, tanti prodotti caratteristici dell’Italia hanno successo fra gli stranieri: pensiamo alle specialità alimentari (e non solo la pizza), ai capi di alta moda, ai mobili e alle creazioni dei nostri artigiani.
Non basta «unire fra loro» le economie per essere tutti uguali. Possiamo vendere la Vespa nel mondo, ma dove non ci sono le strade o i distributori di benzina serve a ben poco. A scuola toccherà andarci a piedi e impiegare un sacco di tempo, proprio come fanno questi bambini. Acquistare prodotti – o assimilare abitudini – di altri Paesi può essere un modo per scoprire culture diverse dalla propria, ma non è suffciente a garantire a tutti le stesse opportunità. Oggi rimane netta la divisione fra gli Stati economicamente sviluppati e quelli in diffcoltà. Per ridurre questo squilibrio servirebbe una distribuzione più equa delle risorse, a partire da quelle alimentari.
Il confine che separa il Nord e il Sud del mondo passa anche dal modo in cui scegliamo di consumare il cibo. Mentre in alcuni Paesi africani, asiatici o dell’America latina la popolazione patisce la fame, negli Stati più ricchi si organizzano campagne informative contro l’obesità, un fenomeno sempre più diffuso. Anche dal punto di vista alimentare, insomma, siamo ancora lontani da una condizione di effettiva uguaglianza. Il primo passo per garantirla è ridurre gli sprechi, sia quelli dell’industria sia quelli che riguardano la nostra vita quotidiana. Come si può fare? Pensiamo a un esempio che ci riguarda da vicino: quante volte buttiamo via il cibo avanzato a tavola?
Secondo i dati forniti nel 2014 dalle Nazioni Unite nel rapporto The State of Food Insecurity in the World («Stato dell’insicurezza alimentare nel mondo»), le persone che non sono sufficientemente alimentate sono 805 milioni. Nel rapporto si sottolinea come la lotta alla fame stia conseguendo risultati rilevanti, e infatti la situazione sta progressivamente migliorando: si pensi che solo venti anni fa, agli inizi degli anni Novanta, le persone sottonutrite erano più di un miliardo. L’area del mondo dove questo problema si manifesta con più evidenza è l’Africa subsahariana, dove un quarto della popolazione è cronicamente sottoalimentato. A causa delle guerre, in alcuni Paesi africani la situazione è ancora più grave, perché a soffrire per la fame e la denutrizione è a volte anche più della metà della popolazione. In America latina e in Asia si sono riscontrati i maggiori progressi, ma in Asia sono più di 500 milioni le persone che soffrono la fame e la maggior parte di esse sono concentrate in Cina e in India, che oggi sono tra le principali potenze economiche mondiali.
In tutti i Paesi del mondo l’agricoltura riveste un’importanza fondamentale, poiché è da essa che dipende l’alimentazione di miliardi di persone. In passato, le guerre o i periodi prolungati di siccità e di freddo scatenavano drammatiche carestie. Le ultime grandi carestie si sono verificate nella seconda metà del Novecento in Africa e in Asia, ma ancora oggi centinaia di milioni di individui non riescono ad avere un’alimentazione adeguata. Nel 2000, con la Dichiarazione del millennio, le Nazioni Unite si sono impegnate a migliorare le condizioni di vita della popolazione mondiale. Tra gli otto campi di intervento che sono stati individuati per raggiungere questo obiettivo, il primo riguarda proprio la lotta alla povertà estrema e alla fame.
Nella questione alimentare quello della fame (o denutrizione) non è l’unico problema: non è sufficiente nutrirsi, ma è importante anche farlo correttamente. Altri dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’agenzia delle Nazioni Unite, ci informano infatti che circa 1,4 miliardi di persone si alimentano male. Il problema della malnutrizione non riguarda solo il Sud del mondo ma anche i Paesi sviluppati, dove l’ipernutrizione e l’obesità hanno dei costi economici e sociali elevatissimi. Tra le cause principali della malnutrizione nei Paesi sviluppati c’è la diffusione del cosiddetto junk food («cibo spazzatura»), che ha un bassissimo valore nutrizionale ed è molto ricco di grassi e zuccheri. È questo il cibo più economico servito nelle grandi catene di fast food, che si sono diffuse a macchia d’olio in tutto il mondo. Globalmente, il costo della cattiva alimentazione (spese sanitarie per curare le patologie derivate, spese di assistenza per i casi sociali più gravi, perdita di reddito per le malattie e le infermità) è calcolato in 3500 miliardi di dollari, vale a dire 500 dollari per ogni abitante del pianeta.
L’aumento della produttività delle coltivazioni, ottenuto sfruttando più intensamente i terreni e utilizzando specie più produttive, ha in parte risolto il problema della fame ma ne ha sollevato un altro: quello della sostenibilità ambientale di questo tipo di produzione. Oggi l’agricoltura ricorre massicciamente a prodotti chimici e utilizza enormi quantitativi di acqua, mettendo in serio pericolo gli equilibri ecologici di estese regioni della Terra. I terreni infatti non possono essere sfruttati a lungo e l’acqua – come sappiamo – non è un bene che si riproduce infinitamente, ma va utilizzata con parsimonia. La questione della cosiddetta «sostenibilità alimentare» è da anni sull’agenda delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, ed è stata anche tra i temi dell’Expo di Milano del 2015.
La sicurezza alimentare si ha quando un Paese è in grado di garantire un’alimentazione sufficiente e sana alla popolazione, con la conseguente diminuzione del rischio di denutrizione (Testo 1). Viceversa, laddove in molti soffrono la fame, il cosiddetto «indice di rischio alimentare» aumenta: significa che le persone non hanno accesso al cibo, oppure che gli alimenti costano troppo o, ancora, che sono di qualità scadente. L’indice di rischio alimentare tiene conto di vari fattori: non solo lo stato di salute della popolazione, ma anche eventuali conflitti in corso o disastri naturali che possano pregiudicare le risorse alimentari. Secondo il rapporto del 2014 della faO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), 805 milioni di persone nel mondo soffrono la fame (una su nove). Lo stesso rapporto, tuttavia, segnala che dal 1990-1992 il numero degli individui denutriti è diminuito di 209 milioni. Per alcuni studiosi, fra le ragioni di questo cambiamento troviamo anche la globalizzazione.
Nel maggio 2015 è stata inaugurata nella città di Milano l’Esposizione Universale, che per comodità è indicata spesso come Expo 2015. Un’Esposizione Universale è un evento che coinvolge (quasi) tutti i Paesi del mondo: si tratta di una manifestazione che ha lo scopo di promuovere l’innovazione e il progresso, ma anche di educare il pubblico intorno a un determinato tema. Il Paese che la ospita invita gli altri Stati a partecipare con un proprio padiglione (cioè uno spazio espositivo), dove ognuno di essi presenta una selezione di prodotti. L’Italia ha scelto di dedicare l’edizione 2015 a una tematica particolare: Nutrire il pianeta. Energia per la vita. L’Expo di Milano ha avuto quindi come fulcro il cibo, il quale da una parte rappresenta uno degli aspetti tipici del nostro Paese, dall’altra è anche un argomento di strettissima attualità. L’alimentazione è uno degli aspetti che più rappresenta le differenze culturali tra un popolo e l’altro. Un tema molto importante poi riguarda le modalità con cui coltiviamo e alleviamo: come e quanto stiamo sfruttando le risorse del nostro pianeta? Il cibo inoltre è al centro di numerose ricerche scientifiche legate all’innovazione: pensiamo solo al dibattito sugli Ogm. Tutti questi spunti hanno in comune un principio fondamentale: mangiare ci serve per vivere, e come tale è un diritto. Negli ultimi anni, il diritto al cibo è stato spiegato in due modi: il diritto alla sicurezza alimentare e il diritto alla sovranità alimentare.
TESTO 1
La sicurezza alimentare esiste quando tutti gli esseri umani hanno, in qualsiasi momento, un accesso fisico ed economico a un’alimentazione sufficiente, sana e nutriente, permettendo loro di soddisfare le loro necessità energetiche e le loro preferenze alimentari, così da poter condurre una vita sana e attiva.
(da Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare fao, Vertice mondiale sull’alimentazione, Italia, 1996)
Tra i Paesi in via di sviluppo, infatti, quelli che si sono aperti al commercio globale hanno registrato percentuali maggiori di crescita economica. Questo ha permesso loro di ridurre la povertà, e dunque la fame, con maggiore efficacia. Il dibattito però rimane aperto: la globalizzazione è un fenomeno complesso, e l’operato delle multinazionali che ne sono protagoniste può avere effetti molto negativi sulle popolazioni locali. Questo ci porta a un secondo concetto: la sovranità alimentare (Testo 2).
L’attenzione si sposta sul modo in cui le persone hanno accesso agli alimenti. Non si tratta più di avere semplicemente disponibilità di cibo (magari grazie agli aiuti umanitari internazionali). Si tratta di produrre in base a ciò che serve alla popolazione, il che non sempre coincide con le esigenze del mercato globale. Vediamo un esempio nel Testo 3.
TESTO 2
La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, e anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Questo pone coloro che producono, distribuiscono e consumano alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari, e al di sopra delle esigenze dei mercati e delle imprese.
(da Dichiarazione di Nyéléni – Forum internazionale sulla sovranità alimentare, Mali, 2007)
TESTO 3
Oggi l’India produce più latte, zucchero e cereali di quanti ne abbia mai prodotti in passato. Eppure nel marzo del 2000, il governo indiano ha annullato le restrizioni sull’importazione di 1400 prodotti, tra cui latte, cereali, zucchero, cotone, tè, caffè e olio di palma. E tutto ciò malgrado la sovrabbondanza di questi prodotti sul mercato interno, che di conseguenza devono essere esportati all’estero. Tecnicamente l’India è libera di esportare la sua produzione agricola, ma in pratica gran parte di essa non può essere venduta all’estero perché non risponde agli «standard ambientali» dei Paesi sviluppati. Voi infatti non mangiate mango ammaccati, banane con punture di zanzare o riso con qualche tonchio (un insetto le cui larve mangiano i semi delle leguminose), mentre noi indiani non badiamo a una zanzara di troppo o a un tonchio di passaggio. Di fatto l’economia rurale indiana, che sostiene 700 milioni di persone, oggi viene strangolata. Gli agricoltori che producono troppo sono allo stremo, gli agricoltori che producono troppo poco sono anch’essi allo stremo, e i braccianti senza terra sono disoccupati perché le grandi proprietà e le fattorie licenziano i loro operai. E tutti si affollano nelle città in cerca di lavoro.
(adattato da A. Roy, I nuovi colonizzatori, “Internazionale”, 10 ottobre 2002)
Viviamo ai tempi della globalizzazione. Lo sentiamo ripetere ogni giorno, alla televisione, sui giornali e su tutti gli altri mezzi di comunicazione. Ma che cosa significa esattamente? La globalizzazione è un processo di integrazione tra i Paesi del mondo, che sta cambiando soprattutto il settore dell’economia ma che ha ripercussioni anche sugli altri aspetti – politici, culturali, sociali – della vita delle persone in ogni angolo del pianeta. Per esempio, molti indios dell’Amazzonia non avranno mai sentito pronunciare la parola «globalizzazione», ma di certo ne avvertono gli effetti nelle attività di diboscamento della foresta pluviale che sottraggono loro territori e risorse vitali. La globalizzazione si è affermata grazie alla facilità del trasporto di merci e persone, allo sviluppo del settore dei servizi (a partire da quelli finanziari) e alla grande rapidità con cui è diventato possibile comunicare. Il risultato è che una parte crescente della popolazione mondiale tende a produrre e a consumare alla stessa maniera e ad adottare gli stessi stili di vita: frequenta i fast food, indossa una certa marca di scarpe, vede l’ultimo film di Hollywood, utilizza lo smartphone ecc. La globalizzazione è un fenomeno molto complesso, con il quale oggi abbiamo tutti a che fare e del quale è bene conoscere vantaggi e svantaggi.
La globalizzazione garantisce vantaggi sia culturali sia economici. I vantaggi culturali della globalizzazione sono di vario tipo. Alcuni sono forse più scontati: grazie ai satelliti, per esempio, possiamo vedere in diretta le Olimpiadi e altre manifestazioni sportive, anche se si svolgono all’altro capo della Terra. Altri vantaggi sono più complessi e importanti. Basta un esempio: il confronto tra diverse culture, scardinando vecchi pregiudizi, ha contribuito in molte regioni del pianeta alla conquista di maggiori diritti da parte delle donne e a un loro maggiore coinvolgimento nel mondo del lavoro. Non è poi da sottovalutare l’importanza della condivisione delle conoscenze, in particolare quelle scientifiche, che oggi si diffondono a una velocità straordinaria grazie agli strumenti forniti da Internet e all’utilizzo della lingua inglese. Per quanto riguarda i vantaggi economici, la globalizzazione ha favorito l’apertura di ogni Paese ai commerci mondiali, permesso ovunque l’introduzione di tecniche di produzione nuove e più efficienti, facilitato la ricerca di lavoro oltre i confini dei singoli Paesi. Grazie a ciò, negli ultimi decenni, centinaia di milioni di persone hanno conquistato un tenore di vita più dignitoso.
Le critiche alla globalizzazione pongono l’accento sugli svantaggi di natura culturale, economica e sociale. La diffusione veloce di stili di vita da un continente all’altro può causare una perdita di identità culturale: tradizioni legate alle realtà locali – testimonianza delle diversità che caratterizzano il genere umano – tendono a scomparire, sommerse da modelli culturali globali dominanti, spesso veicolati da martellanti campagne pubblicitarie in televisione, sui giornali e su Internet. Anche i rischi economici e sociali sono consistenti. Le maggiori compagnie del mondo conquistano facilmente ampie fette di mercato a scapito dei prodotti e dei commerci locali, causando il fallimento degli operatori economici del luogo. Spesso tali compagnie si configurano come gigantesche multinazionali, aziende di grandi dimensioni che distribuiscono le loro attività in più Paesi, operando anche in settori economici diversi. Lo strapotere delle multinazionali dell’agricoltura, per esempio, provoca la perdita di coltivazioni di piante locali selezionate attraverso i secoli e la diffusione delle medesime coltivazioni in tutti i continenti a seconda della richiesta dei mercati internazionali. Infine, la ricerca di profitti maggiori da parte delle aziende causa lo spostamento della produzione nei Paesi dove il costo della manodopera è più basso, portando a un aumento della disoccupazione nei Paesi più sviluppati.
Il corpo di un adulto è composto per il 60-80% di acqua, una risorsa indispensabile per la nostra sopravvivenza. L’acqua ci serve per dissetarci, per cucinare, per lavarci e per pulire, e questi sono solo alcuni dei suoi usi. Si tratta di un bene così prezioso da essere stato soprannominato l’«oro blu», per analogia con il petrolio, chiamato spesso l’«oro nero». Pur essendo una risorsa essenziale per la vita quotidiana, non tutti hanno uguale accesso all’acqua e – secondo alcuni studiosi – la quantità sempre minore di acqua potabile potrebbe addirittura essere all’origine di futuri conflitti.
Se le risorse di acqua sono a rischio e quelle esistenti sono distribuite male, l’unica cosa da fare è utilizzare meno (e meglio) l’acqua che abbiamo a disposizione. Ciò significa innanzitutto ridurre gli sprechi, ma tutti noi possiamo fare qualcosa di più. Possiamo mangiare le verdure più spesso della carne, per esempio. Che cosa c’entra? C’entra con un concetto chiamato «impronta idrica», di cui si parla nel Testo 3, cioè la quantità di acqua necessaria per produrre ciascun alimento.
TESTO 3
Vi siete mai chiesti quanta acqua occorre perché arrivi in tavola una sugosa bistecca o un piatto di pasta al pomodoro? Non stiamo parlando dei bicchieri d’acqua che berrete per mandar giù questi o altri cibi, ma di tutta l’acqua che serve per produrli. A ciascun alimento corrisponde infatti un’«impronta idrica», ovvero quanta acqua è necessaria, direttamente o indirettamente, per produrlo.
(adattato da E. Meli, Arriva la piramide alimentare idrica, “Il Corriere della Sera”, 19 aprile 2011)
Qualsiasi attività economica genera un bene, un oggetto oppure un servizio, che può essere venduto in cambio di denaro. La somma del valore monetario di tutti gli oggetti e i servizi prodotti all’interno di un Paese in un anno costituisce il Prodotto Interno Lordo o Pil. Si tratta di un dato molto importante per quantificare la grandezza dell’economia di uno Stato, poiché misura il corrispondente in denaro di tutto ciò che viene prodotto su quel territorio da individui, aziende private e pubbliche: le automobili, i vestiti, la frutta, ma anche il trasporto pubblico, le cure mediche e tante altre cose. All’interno del Pil si può individuare la quota realizzata da ciascun settore economico, per determinare se la ricchezza di un Paese è più legata all’agricoltura, all’industria, al commercio, al turismo e così via.
Dividendo il Prodotto Interno Lordo nazionale per il numero di cittadini che risiedono in un Paese si ottiene il Pil (o reddito) pro capite, cioè per persona. Anche questo è un dato significativo, perché esaminandolo possiamo farci un’idea del potenziale benessere economico di una popolazione. Prendiamo ad esempio il caso della Cina, attualmente il secondo Paese al mondo per valore del Pil. Se rapportiamo tale dato alla popolazione cinese (1 miliardo e 340 milioni di abitanti circa), otteniamo in realtà una cifra piuttosto bassa. Analizzando il reddito pro capite cinese possiamo quindi dedurre che, nonostante il Paese asiatico sia oggi una delle più grandi potenze economiche al mondo, questa ricchezza non si traduce in un tenore di vita alto per tutti i suoi abitanti.
Una delle maggiori barriere allo sviluppo umano è costituita dalla disparità di genere, ovvero dalle discriminazioni che, ancora oggi, subiscono le donne in vari Paesi del mondo. Per misurare il fenomeno, il Programma di sviluppo dell’Onu ha introdotto nel 2010 l’Indice di Disuguaglianza di Genere (in inglese Gender Inequality Index, Gii). I fattori presi in esame sono la salute riproduttiva, che considera i casi di morte per parto e di gravidanza in età adolescenziale, l’accesso al lavoro retribuito e a posti di responsabilità, e la rappresentanza delle donne nel Parlamento di un Paese. Il valore è espresso tramite una cifra in millesimi che può andare da 0 (perfetta uguaglianza) a 1 e si legge al contrario rispetto all’isu: i valori più bassi indicano i Paesi più virtuosi.
Il Pil pro capite è un primo strumento per misurare la ricchezza di una popolazione; tuttavia per ottenere un valore più attendibile sul benessere non solo economico e sulla qualità della vita degli abitanti di un territorio è necessario considerare altri fattori: si deve prendere in considerazione tutto ciò che permette alle persone di avere una vita lunga e sana, di compiere delle scelte e di partecipare attivamente alla vita economica e politica del proprio Paese, di sviluppare la propria creatività e di raggiungere degli obiettivi. Per questo motivo è stato introdotto nel 1990 l’Indice di Sviluppo Umano o isu. Questo indice viene calcolato ogni due anni dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite prendendo in considerazione, oltre al Pil pro capite, anche la speranza di vita e il livello di istruzione.
L’idea di fondo è che la combinazione di questi tre fattori fornisca un ritratto abbastanza realistico dello sviluppo umano di un Paese, dato che si ricollegano ad altri aspetti fondamentali per la vita umana: la capacità di vivere a lungo e in buona salute è legata al buon livello di alimentazione e di cure sanitarie e alla disponibilità di un’abitazione adeguata; le conoscenze danno alle persone la possibilità di comunicare e di partecipare attivamente alla vita della comunità ecc. L’isu viene espresso in un valore in millesimi compreso tra 0 e 1: quanto più il valore si avvicina a 1, tanto più alto è il livello di sviluppo umano raggiunto dal Paese. Pil, reddito pro capite, isu sono tutti indicatori economici e sociali, cioè dati statistici che danno indicazioni sui diversi aspetti dell’economia di un territorio e sul grado di benessere della sua popolazione.
Uno degli strumenti utilizzati per misurare il benessere delle popolazioni dei vari Paesi è il Pil pro capite, ossia la ricchezza disponibile in media ogni anno per abitante. Come si può vedere dal planisfero, dispongono di un Pil pro capite elevato le popolazioni di quello che è considerato, in senso socio-economico, il Nord del mondo (cioè l’America settentrionale, l’Europa occidentale, il Giappone e l’Australia). È invece basso il Pil pro capite di parecchi Paesi del Sud del mondo (cioè America latina, Africa e Asia). Il Pil pro capite, però, è un indicatore che offre un’immagine «sfocata» del benessere di una popolazione: fornisce infatti la media della ricchezza e non la sua reale distribuzione all’interno della popolazione. In base a questo indicatore, per esempio, due individui che guadagnano rispettivamente 90 e 10 dollari saranno accomunati dalla media di 50 dollari a testa. Se consideriamo che la ricchezza nei Paesi del Sud del mondo è distribuita in modo molto iniquo, ne deduciamo che cospicue parti di quelle popolazioni guadagnano molto meno delle cifre riportate nelle statistiche del Pil pro capite. Per avere un quadro più preciso della qualità della vita dei popoli sono quindi stati creati nuovi indicatori, tra cui l’Indice di Sviluppo Umano e l’Indice di Povertà Multidimensionale.
Le disuguaglianze tra il Nord e il Sud del mondo hanno molte cause: ci limiteremo a illustrarne alcune. In Asia, Africa e America latina è concentrata la grandissima maggioranza della popolazione mondiale, in continua crescita a causa di un alto tasso di natalità. In questi tre continenti si trovano anche estese regioni con condizioni ambientali difficili (deserti, foreste, montagne) e con una storia di scarso sviluppo alle spalle: i loro abitanti devono quindi spartirsi una ricchezza molto limitata. Questi tre continenti dispongono di molte risorse naturali, che sono tuttavia controllate e sfruttate per lo più da ristrette cerchie locali e dalle multinazionali straniere. A esserne beneficiati sono quindi pochi individui e non le popolazioni locali. C’è, in altre parole, un rapporto iniquo nella distribuzione della ricchezza, che avvantaggia solo una piccola parte della popolazione mondiale. Molto dipende inoltre dall’organizzazione economica e sociale dei singoli Paesi. Un’economia ben funzionante promuove lo sviluppo e la popolazione gode di un più alto livello di reddito. Ma perché tale sistema economico si affermi servono conoscenze scientifiche e tecnologiche, risorse da investire, una classe dirigente competente, un apparato statale efficiente e una società pacifica: condizioni che nei Paesi più poveri si verificano di rado.
Per molti anni la geografia dello sviluppo e del sottosviluppo ha subito poche variazioni e il mondo è rimasto diviso tra un Nord industrializzato e ricco e un Sud agricolo e povero. I Paesi del Sud del mondo sono anche definiti «Paesi in via di sviluppo»: accomunati dal passato coloniale e dalla carenza di risorse finanziarie e umane e di infrastrutture adeguate, per lungo tempo non hanno potuto avviare un percorso di sviluppo economico e sociale. Nell’ultimo quarto del Novecento, però, diversi Stati asiatici hanno iniziato a sviluppare il settore industriale. Paesi quali Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong sono stati per questo definiti le «tigri asiatiche», a indicare la loro risolutezza nel promuovere lo sviluppo. In seguito hanno ottenuto buoni risultati altri quattro Paesi asiatici: Malaysia, Indonesia, Thailandia e Filippine. Oggi è il turno di due veri e propri giganti demografici, l’India e soprattutto la Cina, che ha vissuto uno sviluppo industriale e commerciale straordinario, diventando nell’arco di un ventennio la seconda potenza economica del mondo dopo gli Stati Uniti. Accanto a India e Cina, anche tre Stati di altri continenti stanno velocemente guadagnando posizioni nella classifica dei Paesi «emergenti»: il Sudafrica, il Brasile e la Russia. Questi cinque Paesi sono oggi indicati con la sigla Brics, formata dalle iniziali dei loro nomi .